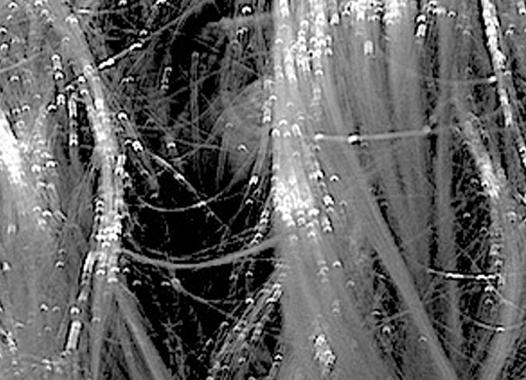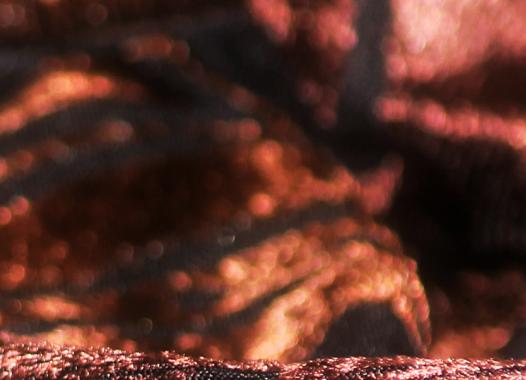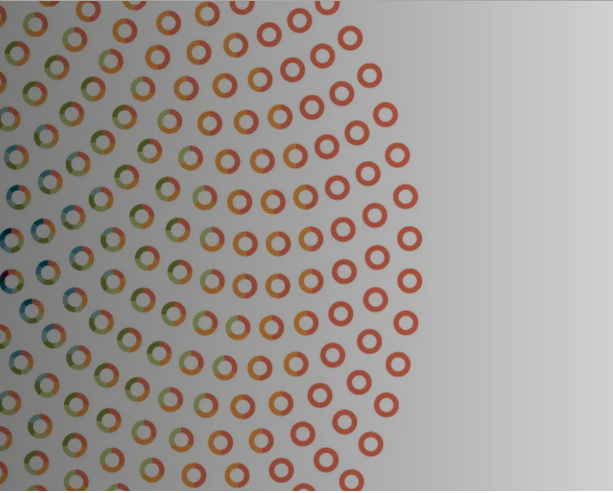1. Il patto magico dell’amicizia
L’Amica geniale ha come protagoniste due amiche, Lila ed Elena, e racconta l’evoluzione delle loro vite e del loro legame dall’infanzia nella misera periferia di Napoli alla maturità, dal 1950 al 2010 (dai sei ai sessantasei anni di entrambe).
L’amicizia, esperienza fondativa per le donne, e tuttavia finora significativamente poco elaborata nell’immaginario universale, emerge nel racconto in modo spiazzante come pratica della differenza: altra rispetto all’ethos classico del legame liberamente stabilito tra pari, perché quel tipo di signoria sulla propria vita è un privilegio maschile e ha storicamente presupposto, come complemento inevitabile, un dominio sul femminile. A Ferrante non interessa l’incontro tra due soggettività che si rappresentano come disincarnate e sovrane, e racconta invece l’amalgama terribile di invidia e riconoscimento elettivo da cui l’amicizia tra due donne, due dominate in cerca della loro emancipazione, inevitabilmente è costituita. Pur arrogandosi lo stesso statuto di libertà dei legami maschili, l’amicizia di Elena e Lila emerge, nel corso del tempo, come una fusione di trascendenza e immanenza: amore e astio, slanci ed egoismi, confessioni e segreti, convivenze e distacchi si succedono e si intrecciano durante la loro relazione tempestosa. "Ci prendemmo per mano e andammo"
Ci sedemmo al tavolo della cucina, mentre Tina e Imma parlottavano a bassa voce muovendo sul pavimento bambole, carrozze e cavalli. […] Quanto tempo era che non ci impegnavamo insieme in qualcosa. […] Le nostre teste urtarono – a pensarci, per l’ultima volta – l’una contro l’altra, a lungo, e si fusero fino a diventare una sola. (Sbp, 292-294)
Le bambole, Piccole donne, La fata blu, le scarpe: tutti simboli del potere trasformativo dell’amicizia, grazie al quale la violenza del rione si muta in un gioco che a sua volta genera un oggetto-talismano, un esorcismo della logica feroce degli adulti. Oltre che un talismano, l’oggetto è anche come l’ambra evocata da Mandel’štam: una resina solida che trattiene un fossile potenzialmente vivo dentro di sé. Ognuna di queste creazioni, infatti, racchiude un nucleo di violenza, neutralizzato e quindi reso estetico, meraviglioso dall’amicizia, ma sempre pronto tuttavia a sprigionarsi nuovamente. Non a caso proprio due di questi oggetti, le bambole (Tina e Nu), aprono e chiudono la lunga narrazione, prima con la loro scomparsa e poi, cinquantasette anni dopo, con la loro enigmatica apparizione: esse evocano l’inizio e la fine del tempo magico (lo sprofondamento e la riemersione dal magma di Napoli), ma anche la cifra di una narrazione femminile totale, in cui la bambola è il simbolo di una ciclicità che accoglie in sé l’amica, la bambina e la madre. L’intera parabola dei Neapolitan Novels può essere letta come la storia del progressivo depotenziamento del patto magico dell’infanzia: il forziere di monete d’oro è diventato il tiretto della cassa della salumeria di Stefano, la fata blu si tramuta nell’anonima e generosa professoressa dai capelli turchini che dischiude a Elena le porte della Normale, e così in un controcanto inesorabile il clamore di mondanità sociopolitica suscitato dall’articolo contro i Solara è ciò che resta della formidabile guerra che Lila voleva scatenare contro di loro. "I sogni della testa sono finiti sotto i piedi" (Ag, 310): in questo modo Lila commenta le scarpe da sposa che ha appena indossato, le scarpe pensate da lei quando era solo una bambina e che, alla visione del primo modello, le avevano suscitato "un’emozione violentis- sima, come se le fosse apparsa una fata e le avesse realizzato un desiderio" (Ag, 301). Tutto, in Elena e Lila, è sotto il segno della simbiosi: la nascita a pochi giorni l’una dall’altra, i diminutivi dei nomi propri – bisillabi, intrecciati nelle allitterazioni (Lila e Lenù) e poi sdoppiati in quelli delle due figlie (Tina, oltre ad essere il nome della bambola di Elena, è anche il diminutivo di Imma) –, l’aspetto fisico e i caratteri opposti e complementari. E, come tutte le simbiosi, il loro legame ha origine dalla compensazione di un vuoto: l’amicizia tra le due bambine ripara la carenza originaria nel rapporto con le madri, anelli di una genealogia del disvalore femminile che si manifesta e si perpetua proprio nel rapporto anaffettivo e deprivato con le figlie. La fusione a volte nasconde a volte enfatizza l’asimmetria del legame, quell’oscillazione vertiginosa tra i due personaggi che Ferrante ha indicato come un tratto forte della dinamica narrativa.
La sua [di Lila] vita si affaccia di continuo nella mia, nelle parole che ho pronunciato, dentro le quali c’è spesso un’eco delle sue, in quel gesto determinato che è un riadattamento di un suo gesto, in quel mio di meno che è tale per un suo di più, in quel mio di più che è la forzatura di un suo di meno. (Snc, 337)
L’invidia, il sentimento generativo di questa amicizia, è un’emozione originata dal riconoscimento elettivo dell’amica, un valore include entrambe in un progetto iniziale ma poi esclude immancabilmente una delle due nella fase successiva. In una reciproca dinamica di esclusione, sia Lila sia Elena sono nomadi in cerca del "territorio meraviglioso" (Ag, 159) da abitare e investono continuamente cose luoghi e persone di questo statuto di Heimat: uno spazio che solo grazie a una ricerca comune riescono a individuare ma del quale poi però solo una delle due può disporre, a patto che non faccia entrare l’altra. L’esperienza femminile è rappresentata come una mutilazione, per cui lo studio implica una rinuncia alla bellezza e alla passione (è il destino di Elena), e la bellezza e la passione impediscono l’accesso allo studio (è il destino di Lila): "era come se, per una cattiva magia, la gioia e il dolore dell’una presupponessero il dolore o la gioia dell’altra" (Ag, 252). Il protomodello di questa dinamica di esclusione è la precoce chiusura del percorso scolastico di Lila (ferma, per volontà dei genitori, alla quinta elementare), su cui da subito si concentrano le ambivalenze di Elena. Per un verso, la bambina pregusta una scuola nella quale sarà finalmente libera dal confronto perdente con l’amica, per l’altro la sua assenza svuota immediatamente l’apprendimento di ogni intensità: eliminarla significa impoverire lo stesso desiderio di conoscenza (Ag, 182- 183). La costruzione dell’identità è il frutto di una reciproca distorsione dello sguardo: Lila reagisce all’esclusione dalla scuola (un "privilegio che lei aveva perso per sempre", Ag, 255) prima studiando clandestinamente il greco, poi creando le scarpe ("è stato, disse all’improvviso, soprattutto un modo per dimostrarti che sapevo fare bene le cose anche se non venivo più a scuola", Snc, 143), e infine spostando progressivamente la competizione con Elena su un altro piano, quello del potere seduttivo; Elena sente l’accorata richiesta di Lila di andare a studiare nella sua casa/prigione di donna sposata con un salumiere ("A che serve?" […] "A sapere che ci sei", Snc, 46) come una conferma del proprio destino di "amica con gli occhiali e i brufoli" (Snc, 46) e, soprattutto, come una possibilità di pienezza estranea al gioco delle addizioni e delle sottrazioni ("mi voleva davvero inchiodata al ruolo di chi passa la vita sui libri, mentre lei […] si prendeva tutto, si concedeva tutto", Snc, 93). La componente diabolica di questa amicizia è svelata dall’epigrafe faustiana al primo volume, nella quale si decanta il valore dello spirito maligno per l’essere umano, di "un compagno che lo pungoli e che sia tenuto a fare la parte del diavolo". L’amica si pone quindi come "fantasma esigente" (Ag, 93): un’alterità incolmabile che – nonostante la tensione simbiotica – non può mai essere ridotta a specchio di sé.
La novità e la forza dell’Amica geniale non sono solo tematiche ma anche, e forse soprattutto, formali. Ferrante – una scrittrice raffinata, sintetica e sperimentale nei suoi precedenti tre romanzi – ha avuto con i Neapolitan Novels il coraggio e l’intelligenza creativa, e questa fu anche la strategia di Elsa Morante, di immettere i materiali dell’intrattenimento e della letteratura di consumo
Ferrante rifiuta non solo ogni lettura esotica di Napoli, ma anche la rimozione della sua oggettiva diversità in nome di un decoro e di un disciplinamento borghese. Uno dei "fondali bassi" che Ferrante draga, da cui ricava l’idea di un intreccio corposo, avvincente, ricco di effetti a sorpresa, soprattutto in clausola dei capitoli, è la sceneggiata napoletana: il genere più ingombrante della cultura popolare partenopea, una messa in scena di canto e discorso intorno alle emozioni primarie. Anche questa forma è una rivisitazione dell’arcaico, una sua riscrittura in un contesto alto (l’inclusione del popolare nel letterario è d’altronde la cifra della migliore sperimentazione napoletana), nel quale il modulo stereotipato della passione, dell’onore e dell’omicidio – la realtà del rione – è usato per raccontare una storia molto più complessa. I tipi della sceneggiata (issa, esso e ’o malamente; ’o zappatore ca nun sa scorda ’a mamma; i figli ca so’ piezz e’ core; ’a malafemmena) diventano personaggi problematici: il camorrista Michele, per esempio, è l’unico personaggio maschile in 1730 pagine che riesce a vivere e a dichiarare una passione d’amore violenta, sofisticata e cerebrale verso una donna (cioè Lila: Sfr, 186-187, 303-306). Proprio all’opposto di quanto accade nel feuilleton o nel thriller, il coinvolgimento del lettore è alimentato per poi essere frustrato. La serialità del genere di consumo è sabotata: nei quattro romanzi dell’Amica geniale i finali dei capitoli non chiudono (e anzi addirittura anticipano lo sviluppo della vicenda), gli assassini o i rapitori non si trovano, le sparizioni non si spiegano, il titolo stesso dell’intero ciclo smentisce le aspettative (è Lila a conferire ad Elena lo status di "amica geniale", non il contrario: Ag, 309).
La spirale di perdita e accrescimento dell’amicizia femminile si traduce poi in un’altra strategia formale particolarmente riuscita: una narrazione polifonica, duale, grazie alla quale la voce narrante di Elena si sdoppia in quella dell’amica
[Lila] è riuscita a inserirsi in questa catena lunghissima di parole per modificare il mio testo, per introdurre ad arte anelli mancanti, per sgan- ciarne altri senza darlo a vedere, per dire di me più di quanto io voglia, più di quanto io sia capace di dire. (Sbp, 16)
La stessa scrittura del romanzo ha origine dal desiderio di colmare magicamente l’assenza di Lila, la sua enigmatica sparizione:
Voglio che lei ci sia, scrivo per questo. Voglio che cancelli, che aggiunga, che collabori alla nostra storia rovesciandoci dentro, secondo il suo estro, le cose che sa, che ha detto o che ha pensato. (Sfr, 91)
Lo sdoppiamento della voce narrante è generato da una focalizzazione sui pensieri di Lila, ottenuta attraverso lo stratagemma del materiale documentario. Elena si appoggia all’autorità degli otto quaderni che l’amica le consegna nel 1966 (Snc, 15-18) e ad essi fa poi continuamente riferimento; una lunga confessione di Lila guida poi il racconto degli anni tra il 1967 e il 1969 (Sfr, 87-153); la testimonianza di sua figlia Imma documenta la passione dell’amica per Napoli verso la metà degli anni Novanta (Sbp, 415- 422). Ogni volume del ciclo si apre con un prologo che fa da cornice (la cui funzione è talvolta ribadita durante la narrazione), e che serve a dare voce all’assente, una voce ammutolita anche a causa della stessa Elena, che ha distrutto proprio quei quaderni così intensi e suggestivi, fonti di invidia e di competizione, ed è ora costretta a ricostruirli attraverso la propria memoria. Questa tecnica narrativa esprime quindi al tempo stesso un esorcismo dell’invidia e una prolessi delle emozioni: grazie ai quaderni, la voce narrante si focalizza su Lila, sui suoi sentimenti, sempre nascosti, e poi su ciò che essi suscitano nella stessa Elena. L’una si fa al tempo stesso sorella ed estranea, garante e rivale dell’esistenza dell’altra, imponendo un agonismo simbiotico – a volte euforico, a volte angoscioso – nel quale però vive e impone il suo diritto di vivere sia chi racconta sia chi si fa raccontare. Questa struttura consente un principio di reversibilità (Elena in realtà è sempre anche narrata da Lila) e una focalizzazione molto mobile, con una distanza della voce narrante da sé stessa – e del lettore dalla voce narrante. Per esempio, quando Elena racconta la notte di nozze e lo stupro dell’amica, tutto procede attraverso la focalizzazione su Lila, autorizzata dal materiale documentario che lei stessa ha affidato a Elena sei anni dopo il matrimonio, avvenuto nel 1959 ("comincio a raccontare il suo viaggio di nozze non solo come me ne parlò […], ma come poi ne lessi sui suoi qua- derni", Snc, 31). Da questo punto di vista, la metamorfosi di Stefano in mostro è incontrovertibile. Ma poche pagine dopo ecco che s’impone un altro punto di vista, secondo il quale questo stesso personaggio esprimerebbe un’umanità mite e tormentata. Mi riferisco al colloquio di Elena con Stefano, avvenuto pochi mesi dopo il matrimonio, durante il quale la ragazza si mostra incredibilmente disposta – nonostante i visibili segni di violenza su Lila e il sintetico resoconto dell’abuso subito – a credere alla bontà e al buon senso di lui e a farsi sedurre dalla sua richiesta di dialogo ("mi piacque l’importanza che mi attribuiva", Snc, 86), al punto da nascondere poi all’amica questo colloquio. La distanza tra i due momenti è creata proprio dalla verità di Lila: una verità che l’io narrante di Elena condivide pienamente solo quando legge i quaderni e quando scrive il racconto della loro vita (nel 2010), ma che il suo stesso io narrato, manipolabile, tende a rimuovere a causa della competizione e dell’ambivalenza durante la conversazione con Stefano. L’oscillazione tra i due punti di vista fa di Elena una narratrice inattendibile e di Lila un personaggio enigmatico. Per un verso Lila è sempre ed esplicitamente cattiva: l’aggettivo la accompagna per tutta la narrazione, insieme al dettaglio degli "occhi a fessura" o "piccoli" (rimpiccioliti cioè dalla rabbia), come un repertorio formulaico cui si associa anche l’evocazione di lei come "strega" (in grado di uccidere i propri figli nell’utero con la sua sola volontà) e poi come "pazza" (in seguito alla perdita di Tina). Per l’altro, però, i gesti di più evidente e lancinante tenerezza nel legame amicale vengono proprio da lei: è Lila che, per esempio, mentre ha le mani ferite dal lavoro di taglio nella azienda di Soccavo ed è immersa nell’odore nauseabondo degli insaccati, bacia con slancio la mano di Elena, venuta ad annunciarle che pubblicheranno il suo primo romanzo (Snc, 461).
La polifonia femminile è anche una risposta sedimentata nella forma a due varianti di monologismo maschile: quello della violenza sul femminile subalterno del rione e quello dell’autismo intellettuale. Tutti gli uomini che nel romanzo hanno una qualche ambizione o capacità intellettuale (dal giornalista all’accademico) possono fare della donna l’oggetto, anche elevato, del loro discorso ma non sono mai in grado di riconoscerla come soggetto: esistenziale, concettuale e creativo. La polifonia di Elena e Lila è una forma parlante e ambivalente: la sola che può dare vita ad un punto di vista femminile in grado di nominare la ferocia cui le donne sono sottoposte senza ridurle al ruolo stereotipato delle vittime, senza fare della narrazione che le racconta una vicenda patetica e lacrimevole. Storicamente rappresentato e percepito dalle stesse donne come silenzioso e invisibile, oppure al massimo come gregario e subordinato, il punto di vista femminile non può mettersi al centro di questa narrazione in modo immediato e irriflesso. Arriva a questa centralità attraverso una complessa costruzione, una premessa e una cornice che rafforzano attraverso lo sdoppiamento la loro ragione d’essere. Solo una circostanza eccezionale giustifica questa centralità: una morte appunto o una sparizione, un’assenza. In questo senso i Neapolitan Novels possono essere associati a due modelli narrativi molto diversi. Il primo è visuale ed è Desperate Housewives, dove la storia è narrata da una morta, da un fantasma che da una dimensione postuma racconta le altrettanto fantasmatiche ossessioni delle proprie amiche ancora vive e del loro mondo residenziale piccolo-borghese. Il secondo è letterario: si tratta di Menzogna e sortilegio, il primo romanzo di Elsa Morante, nel quale – esattamente come nell’Amica geniale – l’io narrante di Elisa si specifica come io scrivente, il cui punto di vista è sostenuto e movimentato – anche in senso ambivalente e antagonistico – dalle false lettere della madre morta, Anna. Come Lila, anche Anna è assimilata a una strega cattiva; le sue azioni e il suo potere seduttivo sono equiparati all’esorcismo e al male- ficio. Le presenze maligne di Anna e Lila hanno quindi nelle due narrazioni il senso di un’energia ambigua ma dotata di una forza redentiva contagiosa, tale da spingere infatti due donne a loro molto vicine (Elisa ed Elena) a prendere la parola anche in nome di un genere ammutolito per millenni. L’intera struttura di Menzogna e sortilegio ha d’altronde molte analogie con L’amica geniale: anche nell’opera di Morante, infatti, la narrazione realista, da grande romanzo ottocentesco, tesa a coagulare il tempo sulla linea direttiva dei destini e del loro compimento, è frammentata e dispersa dalla dimensione magico-favolosa di Elisa (celebri in tal senso i titoli dei capitoli). Si potrebbe parlare, in questa prospettiva, di un realismo magico del Meridione, incarnato dai due romanzi.
3. Una lingua straniera
Per il ciclo dell’Amica geniale, Ferrante adotta una lingua neutra e uno stile medio. Questa scelta ha a che fare in primo luogo con le necessità formali della saga familiare e della sua lunga durata. Ma ha origine anche dalla necessità di raccontare un universo che gravita costantemente intorno a Napoli e al rione Luzzatti, da intendere non solo come luogo individuato (una periferia degradata ai margini della città) ma anche come nucleo centrale dell’interiorità e della creatività di Elena – quindi come luogo oscuro dell’anima, che la sua vita nomade esporta, mimetizza e trascrive (il suo secondo romanzo è una narrazione del rione, con evidenti rinvii meta-narrativi alla stessa Amica geniale) nello spazio della geografia italiana e nei tempi di una vertiginosa modernità (il movimento studentesco, il movimento femminista, le nuove forme quotidiane di politica e aggregazione, le presentazioni dei suoi romanzi, le sperimentazioni di case editrici e convegni). In questo senso Ferrante ha individuato una fenomenologia dell’esilio da Napoli, che riguarda in realtà anche coloro che tuttora risiedono nella città: un esilio in cui molti napoletani (io per prima) potrebbero riconoscersi.
"La plebe è una cosa assai brutta", sottolinea la maestra Oliviero (Ag, 67). La medietà della lingua e dello stile rielabora e traduce l’umanità del rione, che è parte del millenario sottoproletariato urbano napoletano. Violenta, anarchica, subalterna: la "plebe" è la vergogna e la mitologia di Napoli. Quando i borghesi e i piccolo-borghesi napoletani intrecciano le loro vite a quelle del quartiere ostentano un distacco, nel migliore dei casi travestito da filantropia, verso i suoi abitanti. In particolare, sono i docenti delle scuole – dalle elementari al liceo – ad essere i continuatori di quella dissociazione tra ceto intellettuale e popolo di cui già aveva parlato Cuoco. La maestra Oliviero rifiuta di leggere La fata blu perché Lila non può pagarle le lezioni private per accedere alle scuole medie (Ag, 67); è sempre la maestra a rivolgersi alla madre di Elena "come se fosse solo un essere vivente di scarto" (Ag, 203); il professor Gerace ride perché Elena ha pronunciato la parola oracolo con l’accento piano e non sdrucciolo ("non gli venne in mente che, pur conoscendo il significato della parola, vivevo in un mondo in cui nessuno aveva mai avuto ragione di usarla", Ag, 154); la professoressa Galiani invita alla festa dei suoi allievi Elena, ma ignora che la ragazza non è mai entrata in un ascensore (Snc, 152), non ha mai letto o visto leggere un quotidiano (Snc, 132) e meno che mai ha partecipato a una conversazione sulla politica italiana o mondiale (Snc, 157- 160). La Napoli plebea è un’alterità irriducibile.
Ti obblighi […] a lasciarle lo sguardo sulle spalle di ragazzo, sui seni coi capezzoli intirizziti, sui fianchi stretti e le natiche tese, sul sesso nerissimo, sulle gambe lunghe, sulle ginocchia tenere, sulle caviglie ondulate, sui piedi eleganti; e fai come se nulla fosse, quando invece tutto è in atto, […] e ti agita il cuore, ti infiamma le vene. (Ag, 309)
Alla seconda tipologia – definibile come una traduzione all’impronta dal napoletano, quasi dalla sua stessa intonazione vocale, talvolta con un incrocio molto interessante tra indiretto libero e discorso diretto – si può ascrivere la scenata di gelosia di Antonio verso Elena subito dopo il pranzo di nozze di Lila. Si tratta di una miscela che comunica molto efficacemente la carica emotiva e passionale del dialetto:
Mi gridò – un grido stretto nella gola – che lui era lì per me, solo per me, e che ero stata io a dirgli che mi doveva restare vicino sempre, in chiesa e alla festa, io, sì, e me l’hai fatto giurare, rantolò, giura, hai detto, che non mi lascerai sola. (Snc, 22-23)
Filtrando il dialetto, la voce narrante di Elena acquisisce immediatamente un punto di vista strabico, oscillante: visceralmente legato al rione e alla sua "lingua della violenza" (Sfr, 154-155) per una sorta di positivismo dell’eredità familiare, ma anche distante, estraneo; animato da un radicamento inevitabile come pure dalla vergogna e da un bisogno fobico di fuga.
La lingua è anche il genere. Oltre a non essere per Elena una lingua madre, l’italiano non è una lingua parlata dal punto di vista delle donne: l’usurpazione è quindi duplice; il suo linguaggio è doppiamente straniero. La formazione intellettuale di Elena è una costante imitazione delle parole e della postura maschile, una disposizione passiva a recepire e confermare (Ag, 212; Snc, 194; Sfr, 252). Il suo pensiero è una solerte anticipazione; la sua postura quella della "ascoltatrice consenziente" (Sfr, 252), materna. Molto più di un saggio sociologico sui costumi e sull’introiezione del dominio maschile in Italia (che è poi l’oggetto del secondo libro di Elena), il ciclo dell’Amica geniale racconta la formazione di una giovane donna tra gli anni Sessanta e Settanta come il sistematico addestramento di una colonizzata, di un’inferiore oscillante tra "risentimento e subalternità" (Sfr, 219). L’auto-disciplinamento serve a celare dentro di sé "la femmina nella sua espressione più allarmante", confermando però con questa volontà di integrazione la propria natura inferiore di "organismo rozzo che spezzava la fragile superficie del discorso e si manifestava in modo pre-logico" (Sfr, 369). Ancor prima dei contenuti, sono le forme invisibili del discorso, le sue premesse interne – direbbe Foucault – a strutturarsi come logica e pratica egocentrica della casta maschile. Entrambe le strategie investono il linguaggio, e ancor prima il sesso: "l’invenzione della donna" (Sfr, 323) avviene anche in camera da letto. Gli uomini colti e borghesi – naturalmente socialisti, comunisti e aspiranti rivoluzionari – ignorano con placida indifferenza la fisiologia del piacere femminile e il diritto delle donne all’orgasmo. Anche in questo l’universo sottoproletario del rione non è un’alternativa, se dobbiamo basarci sulla sintetica e impietosa formula che per Lila riassume "il fastidio di chiavare»: «molta eccitazione, soddisfazione poca, senso di disgusto" (Sfr, 156). Se si esclude la fase passionale della storia con Nino, vissuta a ben 32 anni, gli scambi sessuali di Elena non sono meno umilianti di quelli discorsivi. L’interlocutrice viene rimossa e si rimuove dall’orizzonte del dibattito, anche qualora il tema in discussione sia connesso alle donne e sia stato sollecitato dalle donne. Ecco una scena fra tante:
Lui [Franco Mari] e Pietro finirono per discutere dottamente sulla coppia, sulla famiglia, sulla cura della prole, persino su Platone, dimenticandosi di me e Mariarosa. Mio marito se ne andò […] contento di aver trovato un interlocutore con cui discutere in modo intelligente e civile. (Sbp, 95)
Dove la tonalità è comica, ma la lettura si fa amara perché a queste scene si continua tuttora ad assistere, anche nell’università italiana.
4. Smarginature e metamorfosi
La smarginatura è la perdita del confine che definisce le forme,
La leggenda di Lila lampeggia sin dall’inizio con la "bambina terribile e sfolgorante" (Ag, 43), e poi con il "bagliore che pareva uno schiaffo vio- lentissimo" (Ag, 260) della giovane splendida donna assimilabile a una divinità. Cocciuta, irragionevole, determinata: per il rione diventa con il tempo "una specie di santa guerriera che spande fulgore vendicativo per lo stradone" (Sbp, 30), che emana "qualcosa di tremendo" (Sfr, 188). I suoi tratti sono sovrumani: lo sguardo è acuto come quello di un "rapace" (Ag, 101, 307), il senso di sé è "esorbitante" (Snc, 120), le scelte ignorano il limite o il buon senso (Ag, 60). Ha il potere di animare le cose, di travasare in esse la tensione della propria mente precoce e poliedrica (Ag, 126, 226). Il suo corpo sprigiona una forza che Elena sente come travolgente (Sbp, 253); il suo intenso erotismo, racchiuso com’è in una fisicità magra, scattante, nervosa, è in realtà potentemente antierotico o quanto meno estraneo ai canoni tradizionali del desiderio maschile. E infatti la sua presenza sollecita negli uomini più adorazione e rispetto che desiderio volgare (Ag, 237, 247). Lila è la medium di una potenza magica che s’insinua nelle maglie rigorose dell’effetto di realtà perseguito dall’intero ciclo narrativo e che contagia prima di tutto Elena, la cui struttura fortemente auto-centrata si regge in realtà su un vuoto di identità continuamente riempito dalla emanazione centrifuga di Lila, dal suo troppo pieno (Snc, 16, 273, 299). Il loro legame è generato proprio dalla smarginatura, sentita come una metamorfosi inarrestabile in cui le due amiche sono "formate, sformate, riformate" (Snc, 454). Un doloroso perdere i propri confini per poi recuperarli, ma in una separazione che si svela poi sempre come intermezzo precario nel flusso ciclico del cambiamento.
Un altro motore profondo di questa energia invisibile è la lotta tra i sessi. Il dominio degli uomini sulle donne è prima di tutto un dominio sulle loro forme fisiche, che si esprime negli uomini borghesi come progetto di colonizzazione del femminile: quella capacità "di espandersi nel femminile, di prenderne possesso" fino a creare "automi di donna" (Sfr, 321, 323), prove viventi dell’onnipotenza maschile. Nella dimensione sottoproletaria del rione, invece, la volontà di dominio è brutale e la rottura della forma femminile va piuttosto nella direzione dell’incorporazione, del cannibalismo.
[Le madri di famiglia del rione] erano state mangiate dal corpo dei ma- riti, dei padri, dei fratelli, a cui finivano sempre più per assomigliare, o per le fatiche o per l’arrivo della vecchiaia, della malattia. (Snc, 102)
A questo stesso processo è sottoposta anche Lila, che "aveva perso forma e si era sciolta dentro il profilo di Stefano, diventandone una emanazione subalterna" (Snc, 124). La deformazione imposta dal maschile non è tuttavia la smarginatura, che è un processo di esplosione dall’interno verso l’esterno, ma la sua premessa necessaria. Significativamente, i primi sintomi di smarginatura che Lila percepisce riguardano proprio il corpo maschile, non quello femminile: sono il fratello e il neo-sposo a essere segnati da una metamorfosi orribile che fa emergere dal loro interno, dalle crepe dell’anima, il primitivo barbarico della violenza sulle donne (Ag, 161; Snc, 41, 80). Lila non subisce però mai passivamente la violenza, al contrario tende spesso a moltiplicarne e a manipolarne le dinamiche (al corteggiamento di Marcello, per esempio, oppone apparentemente, con la scelta di Stefano, un netto rifiuto, ma il suo matrimonio è del tutto interno alla logica camorrista del prevalere, dell’ostentare – come svela il simbolo del fidanzamento: l’automobile sportiva rosso fiammante del salumiere, di gran lunga più costosa e appariscente del millecento dei Solara). La smarginatura è anche un processo affermativo o creativo, che fa fuoriuscire dal corpo femminile un’estrema volontà, uno "spezzarsi per necessità d’odio, per urgenza di vendetta o di giustizia" (Snc, 103). Questo esorbitare da sé genera una fenomenologia ramificata, trasversale: ad esso si ispirano il processo artistico del collage sulla gigantografia del negozio di Piazza dei Martiri (una "autodistruzione in immagine" della propria forma di giovane sposa, Snc, 122), la ricerca su Napoli (rappresentata come uno svanire di sé e della figlia perduta nel più ampio e ambiguo reticolo della città, Sbp, 430), come pure il misterioso gesto omicida che uccide Don Achille Carracci, compiuto non a caso, nella fantasia delle due amiche bambine, da "un essere nerognolo, un po’ maschio ma soprattutto femmina" (Ag, 91).
Smarginare vuol dire infine travalicare i confini del genere, come accade ad Alfonso, "nei cui modi il femminile e il maschile rompevano di continuo gli argini" (Sbp, 255) e la cui progressiva metamorfosi in travestito arriva al suo apice proprio attraverso Lila. È lei che spinge Alfonso verso un’imitazione del proprio stesso corpo, un gioco di specchi spinto fino a "tirargli fuori una parte di sé" (Sbp, 287), al punto che Elena si trova di fronte ad una scena sorprendente:
Il mio vecchio compagno di banco, coi capelli sciolti, la veste elegante, era la copia di Lila. La sua tendenza ad assomigliarle […] si era bruscamente definita, e forse in quel momento era anche più bello, più bella di lei, un maschio-femmina, […] pronto, pronta, a incamminarsi per la strada che porta alla Madonna nera di Montevergine. (Sbp, 151)
Qui Elena evoca un antico pellegrinaggio, quello alla Madonna nera di Montevergine, tuttora celebrato dalle varianti napoletane del travestito, i femminielli. Figura esuberante della diversità, insieme maschile e femminile (come dice già il nome), storicamente riconosciuta e integrata (a differenza dell’omosessuale) nei quartieri popolari napoletani attraverso una serie di riti specifici (tra questi, la figliata: una messa in scena del parto), al femminiello viene attribuito uno statuto magico, associato alla buona sorte, perché rappresenta una unione metafisica dei due sessi.
Mi chiedo come mai questa favola aspra e scomoda che è L’amica geniale sia stata condivisa o anche solo intuita da così tante lettrici e lettori, al punto da fare di questa quadrilogia uno dei testi più apprezzati dell’attuale World Literature. Forse perché abbiamo tutti bisogno oggi di una narrazione che ci mostri dall’interno il nucleo oscuro della nostra contemporaneità, che ci trascini negli strati geologici e tuttavia del tutto sincronici del tempo, che mostri la connessione tra particolare e universale come oggi sanno fare nel mondo i migliori scrittori: coloro che aderiscono in modo più o meno consapevole al cosmopolitismo radicato. Forse abbiamo tutti bisogno oggi che l’arcaico sociale e di genere del nostro contemporaneo e del nostro quotidiano emerga non attraverso un pensiero filosofico o saggistico, ma attraverso una storia. E che infine questa storia si fondi su un evento umano universalmente vissuto e sentito, un evento finalmente visibile nella forma letteraria e nel nostro immaginario: l’amicizia tra due donne.
Article information
Join the colloquy
Join the colloquy
Elena Ferrante
more
When it comes to Ferrante, we may feel, indeed, stranded on a beach, at night, left there to collect the tokens of her presence and whereabouts in this world. The tokens are words and in them we find the lucid exactness of worlds inhabited by characters who are as vivid and real as she is elusive. They deal with what the author has called frantumaglia, a term she borrows from her mother and her Neapolitan dialect (frantummàglia): "it referred to a miscellaneous crowd of things in her head, debris in a muddy water of the brain. The frantumaglia was mysterious, it provoked mysterious actions, it was the source of all suffering not traceable to a single obvious cause" (Frantumaglia, Kindle edition). Ferrante’s compelling narrative dives into terribly muddy waters and surfaces from them with the strength of truth, where truth means not moral clarity but the unmistakable verity of naked human emotions. The origin of the word frantumaglia is very material; it refers, in fact, to a pile of fragments from broken objects that cannot be pieced together again.
This Colloquy seeks to bring together in one ongoing conversation, from a variety of intellectual perspectives, the voices of the international discourse about Ferrante’s novels and the significance of her work in the contemporary literary landscape.
As for who Ferrante might be, I propose again her response to a reader who sought to know her identity: "[. . .] what is better than reading in a room that is dark except for the light of a single reading lamp? Or what is better than the darkness of a theater or a cinema? The personality of a novelist exists utterly in the virtual realm of his or her books. Look there and you will find eyes, sex, lifestyle, social class, and the id" (Frantumaglia, Kindle edition)